Blade Runner 2049: più di un semplice replicante
Pubblicato il 9 Ottobre 2017 alle 13:25
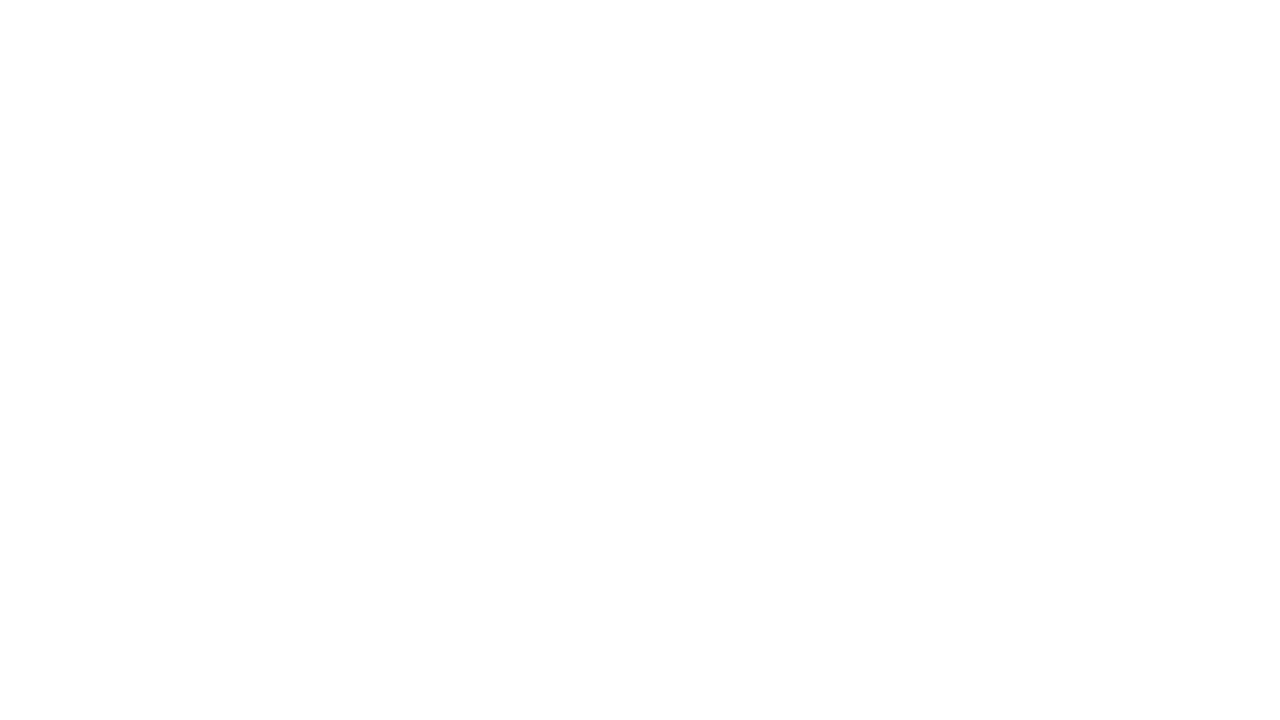
Il sequel di Blade Runner firmato Denis Villeneuve riesce nell’insperata impresa di non far rimpiangere la seminale opera originale.
Era il 1982 quando Ridley Scott cambiò per sempre il cinema di fantascienza con Blade Runner, raccontandoci di quella Los Angeles di un 2019 cupo, affascinante e cinico.
Oggi, a trent’anni di distanza (trent’anni esatti nel mondo del film, qualcuno in più nel nostro), molto è cambiato per entrambi i mondi: quello del cinema si sta dirigendo sempre più inevitabilmente in rotta di collisione con la serializzazione televisiva, favorendo la crescita di produzioni remunerative a quelle più marcatamente autoriali; quello di Blade Runner – che Scott plasmò da un racconto di Philip K. Dick – da cupo, affascinante e cinico che era, nel tempo trascorso fra il 2019 e il 2049 ha iniziato a sgretolarsi, ad appassire, a deprimersi, a raffreddarsi (la pioggia incessante del britannico Scott è diventata candida neve per il canadese Villeneuve).
Colpa di guerre nucleari e radiazioni, colpa di blackout apocalittici, colpa di industrie biotecnologiche prive di scrupoli che hanno intaccato il tessuto della società innestando in essa una nuova razza – quella dei Replicanti, evolutisi dal modello Nexus 6 al Nexus 8 – che per la prima volta dopo molti anni ha iniziato a sognare una possibilità di autonomia, una speranza di liberazione, un desiderio di rivoluzione (figlio della rivoluzione di Deckard e Rachel, che si ribellarono ai diktat della società tramite la fuga d’amore).
Una delle differenze sostanziali fra il film di Scott e quello di Villeneuve sta proprio qui: se il primo Blade Runner fondeva il noir con la fantascienza per mettere in scena tematiche alte e totalizzanti (dalla filosofia alla politica, dalla mitologia alla religione, dalla tecnologia all’ecologia) 2049, come il più intelligente fra i figli d’arte, scivola via dalla gigantesca ed ingombrante ombra del genitore per raccontare una storia che, senza distaccarsi dalle tematiche portanti, diventa molto più umana, molto più intima. E, nel farlo, paradossalmente (e intelligentemente) amplia a dismisura gli orizzonti del mondo in cui ci fa tornare.
Fino ad oggi infatti quel mondo era rimasto circoscritto alle vie bagnate e ai fumosi quartieri al neon dipinti da Scott e dal dop Jordan Cronenweth: Villeneuve e il suo dop di fiducia Roger Deakins (che, arrivato a tredici candidature all’Oscar, quest’anno otterrà finalmente la tanto attesa vittoria) invece, nel raccontarci il viaggio esistenziale di K (un Ryan Gosling dall’occhio vitreo che sembra uscito direttamente dal sottovalutato ma vibrante Solo Dio Perdona), allargano questo universo narrativo mostrandoci di più (ci spostiamo nelle campagne intorno a Los Angeles, arriviamo a San Diego, veniamo spinti fino a Las Vegas, rischiamo addirittura di partire per una colonia extramondo) e giocando a creare, a sognare, a immaginare (una delle scene migliori – fra le tante – sarà interamente basata sui concetti di creazione ed immaginazione, ed è semplicemente sbalorditiva).
Mentre nel primo film l’indagine, piuttosto semplice (trovare i replicanti fuggiti) era il pretesto che Scott sfruttava per parlarci di Dio e della creazione e di decine di altre cose, qui il caso in cui l’agente K si ritroverà impelagato diventa il veicolo che Villeneuve, come un sapiente chauffer, usa per scortarci fra le lande desolate di questo mondo spezzato, che riflette l’apocalisse interiore del nuovo protagonista: la sceneggiatura è meno poetica ma più ambiziosa, più complessa e intricata (e per forza di cose molto meno perfetta), meno universale ma più introversa (quasi freudiana), e più la narrazione prosegue più il mondo si espande a colpi di scenografie visionarie e immagini allucinate.
La proporzione elegante e regale che il regista vuole conferire alla sua opera, poi, può fregiarsi del felice matrimonio con la colonna sonora di Hans Zimmer e Benjamin Wallfisch, che riadattano quella immortale di Vangelis, trasformando la sensualità delle indimenticabili melodie del primo capitolo in una prorompente esplosione di magniloquenza.
E se Blade Runner aveva stabilito linguaggi visivi e stimoli intellettuali che avrebbero influenzato le opere di genere successive, Blade Runner 2049 recupera ed estrapola quei linguaggi e quegli stimoli dalla miglior fantascienza degli ultimi 30 anni (si notano influenze tematiche e/o grafiche da Terminator, A.I. Intelligenza Artificiale, Her, Ex-Machina, che è figlio di Blade Runner nonostante sembri un suo prequel, ci sono gli ologrammi del recente Ghost in the Shell, c’è il giallo ocra di Mad Max: Fury Road, con una specifica inquadratura che rende omaggio a George Miller) riadattandoli però e soprattutto inglobandoli nella specifica unicità di questo universo, pulsante, coerente e vivo come non mai.
Gli onnipresenti occhi del primo capitolo (non solo specchio dell’anima, ma anche segno di distinzione fra umano e replicante) vengono tralasciati in favore dei concetti di memoria e ricordi. Con due sole eccezioni: la prima riguarderà proprio Rick Deckard e sarà collegata al concetto di memoria (di più non posso dire) mentre la seconda, ancor più interessante, è rappresentata dal personaggio di Jared Leto (ridondante e spesso e volentieri didascalico, uno dei pochi difetti del film), la cui cecità diventa metafora di assenza di empatia, quell’empatia che invece dimostrava il replicante Roy Betty nelle tragiche ed emozionanti scene finali di Blade Runner (un altro difetto è la villain inutilmente sadica, quasi a livelli fastidiosi, che entra in forte contrasto con le dinamiche contemplative del film).
Forse mai come prima d’ora un secondo capitolo si è dovuto misurare con un’opera originale tanto importante e irripetibile, ma Denis Villeneuve è riuscito nell’impresa. Questo film non è un capolavoro, e forse neppure il suo lavoro migliore (checché ne dica il buon Denis, l’onore se lo giocano ancora Sicario ed Enemy), ma sicuramente è una prova tecnico-visiva che non ha precedenti e anche uno dei migliori sequel della storia del cinema: non solo non fa rimpiangere il primo capitolo, ma lo aggiorna con sapienza e senza provare ad emularlo riesce splendidamente a trovare una propria strada e una propria ragion d’essere.
Per questo Blade Runner 2049 è un trionfo: perché si inserisce nella moderna necessità del mondo del cinema di creare la serialità, senza per questo tralasciare l’impianto artistico, qui ricercato e impressionante.


