CinemaForever #7: Akira Kurosawa, l’ultimo samurai del cinema mondiale
Pubblicato il 17 Agosto 2016 alle 12:00
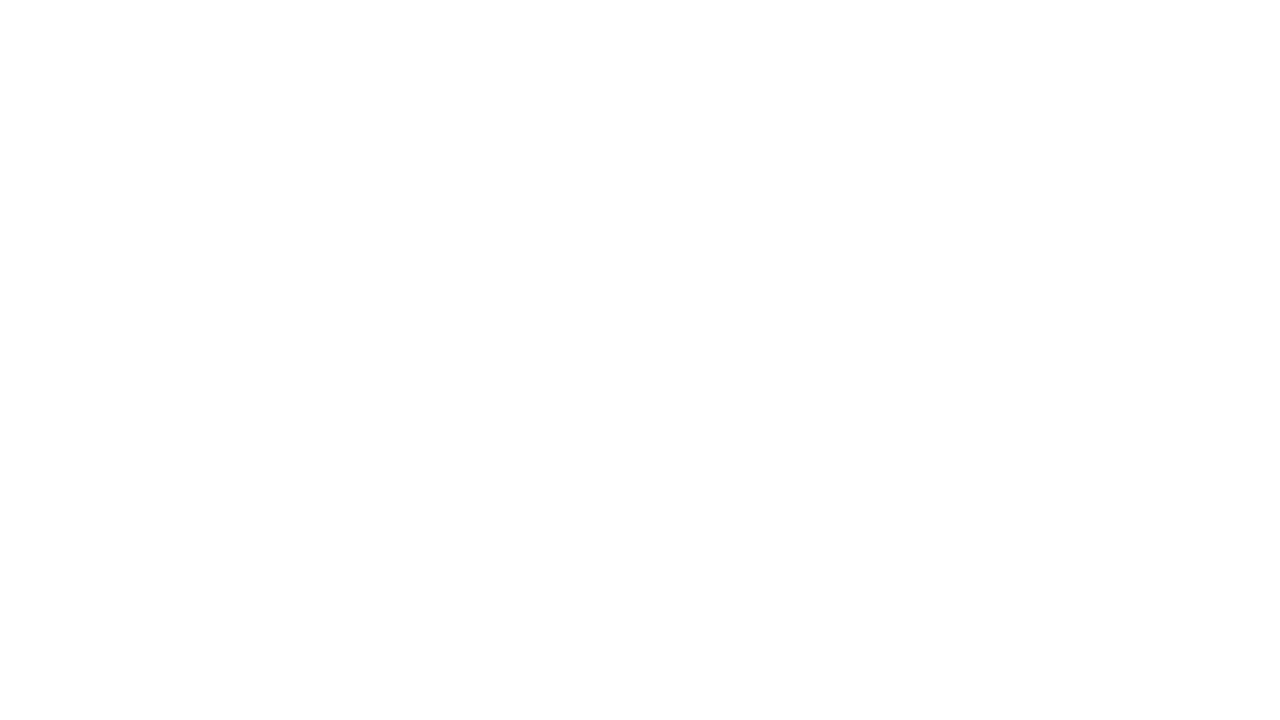
Torna la rubrica preferita dei cinemaniaci! In questo settimo appuntamento, CinemaForever vi parlerà del più importante e imitato cineasta giapponese, che ha imposto il suo marchio a tutto il XX secolo della settima arte: Akira Kurosawa.
Il cinema racchiude in sé molte altre arti; così come ha caratteristiche proprie della letteratura, ugualmente ha connotati propri del teatro, un aspetto filosofico e attributi improntati alla pittura, alla scultura, alla musica.

Discendente di una nobile casata di samurai e grande appassionato di William Shakespeare, il giovane Akira cresce appassionandosi all’arte teatrale e a quella cinematografica. Non si contano le influenze dalle quali si lascia affascinare in età giovanile: dal mondo del cinema assimila gli insegnamenti americani di Chaplin e Ford, quelli espressionisti del tedesco Lang, quelli surrealisti e impressionisti dei francesi Dulac, Clair e Jean Renoir, passando per il metodo russo di Alexander Dovzhenko.
E se con un occhio Kurosawa guardava con ammirazione all’arte visiva del cinema, con l’altro occhio assorbiva con avidità la sapienza infusa negli scritti teatrali, orientali ma anche occidentali, che torneranno più volte nel corso della sua filmografia (Il Trono di Sangue è ispirato a Macbeth, così come Ran lo è a Re Lear e L’Idiota, ovviamente, è la trasposizione del celebre romanzo di Dostoevskij).
Ma la sua visione d’insieme scrutava da lontano Hollywood, col sogno di conquistarla. Non a caso la sceneggiatura di Anatomia di un Rapimento, il suo ventitreesimo lungometraggio, è ispirato da un romanzo del compianto Ed McBain: in questa intramontabile pellicola Kurosawa dimostra una volta di più la sua impareggiabile versatilità destreggiandosi alla perfezione in quello che è sotto ogni aspetto un noir all’americana puro e semplice.
Il regista però va oltre, plasmando un espediente narrativo e fotografico che verrà ripreso più avanti e da Coppola (in Rusty il Selvaggio) e da Spielberg (in Shindler’s List), e cioè il dettaglio a colori in un film in bianco e nero (grossomodo lo stile grafico che verrà adottato da Frank Miller in Sin City circa trent’anni dopo).
Poliedrico, dunque, forse uno dei più poliedrici registi di sempre, Akira Kurosawa, ma ad oggi il suo nome viene il più delle volte accostato ad una parola: samurai.

E’ forse infatti I Sette Samurai la sua pellicola più rappresentativa, che fin dalla sua uscita (1954) si è fatta emblema di un intero genere cinematografico e che nel corso degli anni ha ispirato tutte le generazioni di artisti successive.
Ai più giovani fra voi che prossimamente andranno al cinema per vedere Denzel Washington e Chris Pratt in I Magnifici Sette: sappiate che il remake di Fuqua, così come l’originale del 1960 di John Sturges con Steve McQueen, non è altro che una riproposizione in salsa western de I Sette Samurai.
Così come La Sfida del Samurai (1961) ha ispirato Per un Pugno di Dollari di Leone e a La Fortezza Nascosta (1958) si deve addirittura Star Wars, per stessa ammissione di George Lucas: il cinema di Kurosawa, a metà tra simbolismo onirico e fedelissima ricostruzione dell’affascinante tradizione storica del Giappone feudale, è uno di quei pochi esempi nella storia del cinema che segna il passaggio da un’età all’altra.
Indimenticabili Dersu Uzala, una poesia tradotta col linguaggio cinematografico più intimista, e Kagemusha, imponente film di guerra che descrive in maniera sublime e insuperata il Giappone medievale.
Kurosawa in giovane età ha preso molto da Hollywood e il cinema occidentale, per poi restituire nel corso della sua carriera. Allo stesso modo l’odierna Hollywood e l’odierno cinema occidentale devono molto a Kurosawa, e infatti l’industria del cinema mondiale questo lo ha sempre riconosciuto.

Se da un lato Spielberg, in un certo senso, ricambiò il favore per quel magnifico trucco colorato che Kurosawa aveva orchestrato in Anatomia di un Rapimento aiutandolo, insieme a Lucas, a produrre Sogni (terzultima pellicola del regista giapponese, nella quale compare anche Martin Scorsese nei panni di Vincent Van Gogh), la critica occidentale osanna l'”Imperatore del Cinema del Sol Levante” con 2 premi Oscar al miglior film straniero (su 4 nomination, 5 se contiamo quella per la miglior regia per Ran), e un Oscar alla carriera nel 1990, otto anni prima della scomparsa del regista.
Anche l’Europa ha premia le sue gesta artistiche, con un Leone d’Oro (1951, per Rashmon) e uno d’Argento (1954, per I Sette Samurai) su cinque nomination alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, una Palma d’Oro a Cannes (nel 1980 per Kagemusha), un Orso d’Argento per la Miglior Regia al Festival di Berlino (nel 1958, per La Fortezza Nascosta) e tantissimi altri premi nei tantissimi altri circuiti mondiali ai quali i suoi lungometraggi hanno partecipato.
Sapiente esploratore del confine fra realtà e menzogna, dimostra tutta la sua sensibilità relativista con Rashmon, pellicola che stabilisce un nuovo canone di narrazione che farà la fortuna di numerosi cineasti contemporanei: la stessa vicenda viene raccontata più volte da personaggi diversi, ognuno dei quali fornisce allo spettatore la sua propria versione dei fatti, spesso discordante con quella precedente e con quella successiva.
La pellicola è una delle migliori parabole sul relativismo mai concepite dal cinema mondiale, con la quale Kurosawa vuole insegnare l’impossibilità per l’uomo di arrivare ad una verità assoluta.
Un visionario tanto in vita quanto nell’ora del tramonto, Kurosawa intitola Madadayo il suo ultimo lungometraggio:まあだだよ, la cui traduzione letterale è “Non Ancora”, frase che nella cultura nipponica si riferisce alla morte. Che infatti arriverà qualche anno dopo, implacabile e spietata.
Ma come accade per tutti i grandi, anche per Akira Kurosawa la fine è sfociata nell’eredità, che rimarrà per sempre intramontabile, affascinante e affilata: come la katana di un ultimo, indimenticabile samurai.



