CinemaForever #2 – Alejandro González Iñárritu: l’ego, e i virtuosismi del dolore
Pubblicato il 11 Maggio 2016 alle 12:00
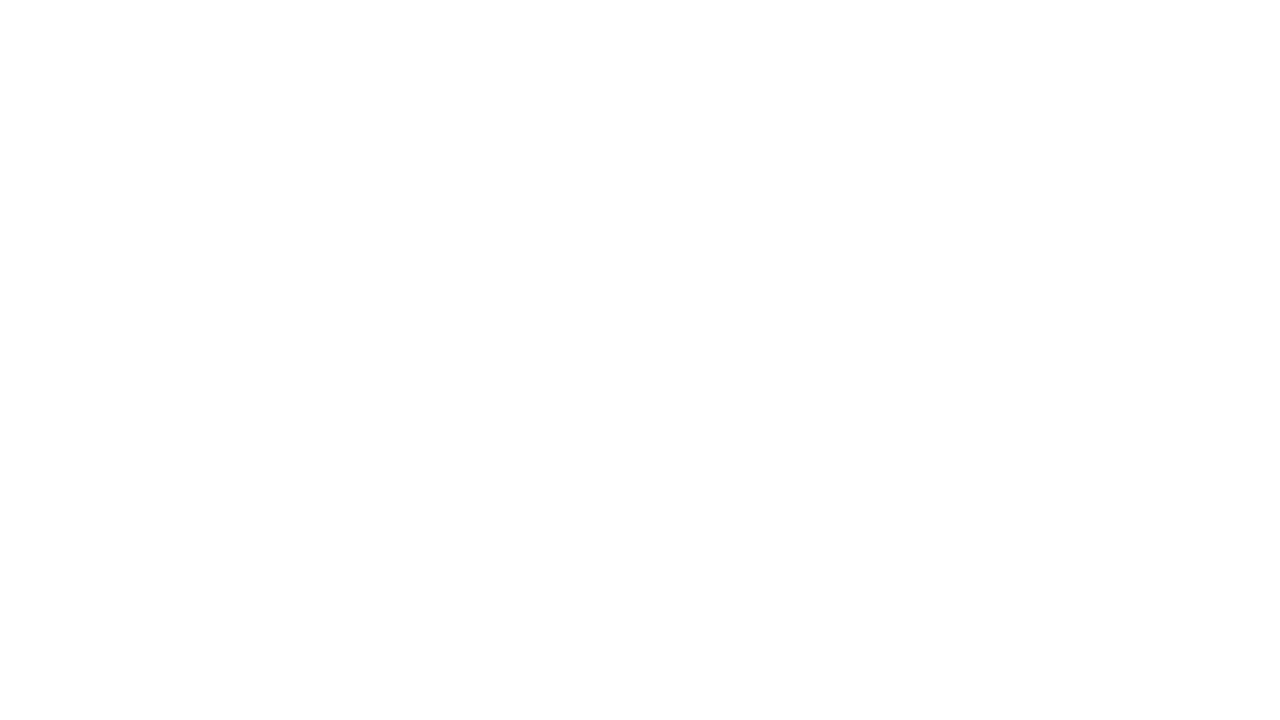
Il primo regista messicano a ricevere una nomination agli Oscar. Il primo regista messicano a ricevere una nomination ai Directors Guild of America. Il primo a vincerne due consecutivamente. L’unico messicano a trionfare a Cannes. E, insieme a John Ford e Joseph L. Mankiewicz, l’unico a vincere due Oscar alla regia consecutivi. Oggi, a CinemaForever, parleremo del cinema di Alejandro González Iñárritu.
Adoro fare cinema. Ma l’unico motivo per cui lo faccio è che sono un pessimo musicista.
E infatti, non molti lo sanno, ma Alejandro Iñárritu i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo li muove all’interno di una stazione radiofonica messicana, la WFM. E sarà proprio il suo eclettismo in fatto di musica – oltre alla passione per i grandi classici della letteratura esistenzialista – a definire il suo stile registico.
Che, spessissimo, si contraddistingue proprio per la giustapposizione dei silenzi e dei suoni di sottofondo: lo scopo è quello di aumentare l’emozione suscitata da una sequenza, da una parola, da uno sguardo.

Alla fine, però, deve essere lui a prendersi il merito per quell’emozione. Il peso dell’enorme ego che si porta sulle spalle sembra non ricadere su di lui, anzi.
Iñárritu ne è consapevole, e se ne compiace: arriverà a troncare la collaborazione con Guillermo Arriaga, amico di lunga data e sceneggiatore del trittico di lungometraggi noto come Trilogia della Morte, composto da Amores Perros, 21 Grammi e Babel, perché era stato messo in dubbio il chi avesse avuto un maggior peso sulla riuscita dei film. E questo Iñárritu proprio non poteva accettarlo.
Chi? Chi…? Come poteva la critica dubitare, credere che il merito andasse a qualcun altro se non a lui? E allora via Arriaga: dal film successivo, Biutiful, e poi per Birdman e The Revenant, alla sceneggiatura ci ha pensato lui. Così nessuno avrebbe avuto più alcun dubbio.
Tanto per rimanere in tema musicale (e di personaggi dall’ego smisurato), nel suo ultimo album The Life of Pablo il rapper statunitense Kanye West dice: “Fatemi il nome di un genio che non sia anche pazzo“. Ecco: Iñárritu rientra perfettamente in entrambe le categorie.
Influenzato, a livello letterario, da Fuentes, Cortázar, Carver e la filosofia di Proust, e cinematograficamente dai lavori di Scorsese, Fellini, Bergman, Lumet, Tarkovsky e Sergio Leone, nello stile del regista messicano l’emotività si mette al servizio del barocco, e viceversa: il suo tratto filmico, pieno di ingegnosi movimenti di camera, estrosità e fantasia, è costruito ad arte per incantare lo spettatore attento, e allo stesso tempo stabilisce il punto cardine che sta alla base del suo pensiero filosofico: l’angoscia che si camuffa da vero senso dell’esistenza.
Con Amores Perros (2000) dimostra di aver assimilato la lezione narrativa di Pulp Fiction, ma non solo. Ha saputo farla sua, e soprattutto ha capito come piegarla ai propri scopi: il risultato è un ode sul non-senso della vita, sulla casualità dell’esistenza e sull’emotività del tradimento: tutti tradiscono tutti, perfino i cani; è come se Iñárritu ci stesse dicendo che la bestialità è insita nell’uomo. Inizia la Trilogia sulla Morte.

In 21 Grammi (2003) rivede la struttura della sceneggiatura: mescolando le carte in fase di montaggio (ama girare in ordine cronologico, per poi stravolgere la sequenza temporale), crea una diegesi complessa e volutamente confusionaria, fatta di incessanti incedere di flashforward e ripresa attraverso movimenti di camera invasati. Filosoficamente ambizioso ed imponente, il film è una riflessione esistenzialista sul caso, religiosamente conosciuto come Provvidenza, e sulla morte generata in base al tragico rapporto causa-effetto.
Continua a leggere, gira pagina
–
Temi che ritornano nell’ultimo capitolo della triade, Babel (2006),
ennesimo film corale senza un vero e proprio protagonista: il fil rouge è il dolore, e la globalizzazione del dolore.
Torna ancora una volta il gioco a incastri tanto caro all’estetica postmoderna, un meccanismo che abbraccia tre diversi continenti e personaggi che non si conoscono fra loro, uniti però da un singolo e all’apparenza trascurabile dettaglio che stravolgerà le loro esistenze.
Rovesciando le metafora del racconto biblico, nel quale la figura della mitica Torre di Babele voleva spiegare le differenze culturali e linguistiche degli uomini, Iñárritu ci spiega che il fato e la perdita non fanno distinzioni, un pensiero oscuro e angosciante che trova amara soluzione soltanto per chi appartiene alla classe sociale più agiata.
Poi il succitato litigio con Arriaga, e il regista messicano stravolge il proprio modo di fare cinema, tracciando una nuova rotta alla sua filmografia: se la Trilogia della Morte era composta da film dall’ampio cast, con più protagonisti e più storie intessute insieme, tutto il contrario diventano Biutiful (2010), Birdman (2014) e The Revenant (2015).

Nel primo, che Iñárritu pensa e scrive per l’attore Javier Bardem, il concetto di coralità scompare a favore del singolo: non è più la sofferenza generale che interessa al regista, ma quella intimista, personale dell’individuo.
Tutto il suo cinema è caratterizzato da un oscuro e raffinato intellettualismo, ed è alla continua ricerca di concetti sottili e preziosi. Ma a questo percorso di ricerca si affianca la ricercatezza di notevoli ornamenti stilistici, puramente formali e scenografici, solo all’apparenza inutili ma sempre azzeccati e, se non essenziali, quanto meno funzionali.
E’ il caso del finto-unico piano sequenza di Birdman o (L’imprevedibile virtù dell’ignoranza) – unica variante semi-comedy all’interno di una produzione filmica molto pessimistica e cupa – che intrappola il protagonista già intrappolato dal suo proprio ego all’interno dell’ego dell’autore: i sedici stacchi del film sono nascosti artificialmente, con trucchi tecnici e narrativi, studiati già agli albori della sceneggiatura.
Questo artificio è essenziale per raccontare la storia? No. Eppure, non solo conferisce alla pellicola un’aurea estroversa che ha pochi eguali, non solo appaga la vena creativa del regista, ma anche e forse più di tutto il resto perseguita il protagonista, lo ossessiona, mettendo a nudo tutto quelle debolezze che egli stesso si ostina ad ignorare, a nascondere: debolezze che anche Iñárritu teme di avere, ma che proprio coi suoi esorbitanti esercizi di stile meramente rococò tende ad esorcizzare.
Più la sfida è impossibile più lui agogna di dimostrare al mondo di essere capace ad affrontarla, e superarla anche.

Lo ha rifatto con The Revenant, capolavoro più grafico che narrativo, più prestazionale che attoriale, ma di certo un’epopea che a livello visivo ha pochi eguali nella storia della settima arte.
Si sarebbe potuto girare lo stesso film su set? Certo. Sarebbe stato accettabile l’utilizzo di luci artificiali? Ovviamente. Ma Iñárritu ha voluto dimostrarci che a lui, l’unico artificio necessario è quello partorito dal suo genio.
Con la sua ultima pellicola ha segnato un solco ben profondo, il regista messicano, nella storia del cinema.
C’è un prima e un dopo The Revenant: d’ora in avanti, gli standard della violenza su schermo, e della credibilità della violenza su schermo, della crudezza, saranno quelli che l’opera di Iñárritu ha stabilito, e ciò che sarà al di sotto di questi risulterà amaramente finto; le sequenze di azione non necessitano per forza di un montaggio frenetico, se sai come muovere la cinepresa in modo fluido, ondeggiante, come una foglia scossa dallo spostamento dell’aria causato da una freccia scoccata, o lo scorrere dell’acqua ghiacciata di un fiume; e non c’è niente di male nella lentezza, quando è bella come un fiocco di neve che imperla il mondo.


